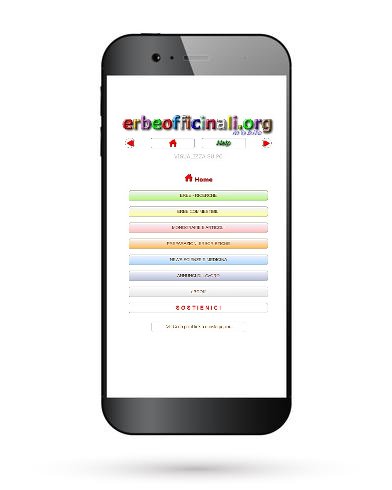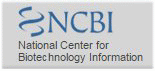|
© I contenuti di questa pagina (escluse le immagini di pubblico dominio) sono di proprietà esclusiva dell'autore Alberto Tucci. Ne è vietata la copia, la riproduzione e l'utilizzo anche parziale in ogni forma. |
| QUESTA SCHEDA È UNICA E ORIGINALE IN INTERNET |
ENULA CAMPANA |
LEGGERE LA SCHEDA IN TUTTE LE SUE SEZIONI PER UNA CORRETTA INFORMAZIONE SULLE PRECAUZIONI D'USO
| COLORI OSSERVATI NEI FIORI |
| ________ GIALLO |
| ________ GIALLO CHIARO |
| ________ GIALLO DORATO |
| DISTRIBUZIONE IN BASE ALLE OSSERVAZIONI UMANE |
 |
| TOSSICITÀ: BASSA |
| Motivazione: L’uso corretto di Inula helenium in preparazioni erboristiche e dosi tradizionali è generalmente ben tollerato. Gli estratti non mostrano tossicità acuta significativa nei modelli sperimentali e, nella pratica clinica o popolare, gli effetti collaterali riportati sono lievi e transitori (ad es. disturbi gastrointestinali minori), indicando un profilo di sicurezza favorevole quando utilizzata appropriatamente. |
| EFFICACIA: BUONA |
| Motivazione: Inula helenium (elenzio/elecampane) è tradizionalmente impiegata come espettorante e balsamico per affezioni delle vie respiratorie e come digestivo/mild stomachico. Numerosi studi in vitro e su modelli animali mostrano attività mucolitica, antinfiammatoria, antimicrobica e broncodilatatrice di estratti o componenti (come l’aleniana e i sesquiterpeni), supportando meccanismi biologici coerenti con gli usi fitoterapici. Tuttavia, gli studi clinici umani controllati sono limitati o preliminari, quindi l’evidenza non è conclusiva per tutte le indicazioni ma è sufficientemente supportata in preclinica e nella pratica tradizionale per indicare un potenziale beneficio. |
| *Note e Bibliografia relativa a proprietà e indicazioni |
| CONTROINDICAZIONI GRAVIDANZA, ALLATTAMENTO, GASTRITE, ULCERA PEPTICA, IPERSENSIBILITÀ ACCERTATA ALLE ASTERACEAE, INSUFFICIENZA RENALE, EPILESSIA, ALLERGIE RESPIRATORIE, BAMBINI SOTTO I 12 ANNI, ASSOCIAZIONE CON FARMACI GASTROLESIVI. NOTA: L'USO PROLUNGATO PUÒ CAUSARE IRRITAZIONE GASTROINTESTINALE. CONSULTARE UN MEDICO PRIMA DELL'USO. |
| AVVERTENZE L'ANTOLATTONE SI LEGA ALLE PROTEINE CUTANEE CAUSANDO DERMATITI DA CONTATTO E IRRITAZIONE ALLE MUCOSE. NON SUPERARE I DOSAGGI CONSIGLIATI, MONITORARE REAZIONI GASTROINTESTINALI, EVITARE USO PROLUNGATO OLTRE 4 SETTIMANE, SOSPENDERE IN CASO DI NAUSEA O VERTIGINI, ATTENZIONE IN SOGGETTI CON ALLERGIE POLLINICHE, PREFERIRE PREPARAZIONI STANDARDIZZATE, EVITARE ASSUNZIONE A STOMACO VUOTO. |
| * Si tenga presente che talvolta la stessa erba indicata come sinergica o antagonista, potrebbe assumere entrambi i ruoli in funzione della dose utilizzata e/o della forma estrattiva o di trattamento come per es. nel Tè (verde o nero). Consultare sempre un fitoterapeuta per personalizzare le combinazioni in base al quadro clinico individuale. |
BIBLIOGRAFIA, WEBLIOGRAFIA E ARTICOLI SCIENTIFICI SUL WEB (Vedi anche i riferimenti nelle singole sezioni) Prova le ricerche di articoli scientifici su Inula Helenium L. |

Inula helenium

Inula helenium

Foto o Immagine modificata per uso didattico

Autore: A.Tucci

Photo by
Arnoldo Mondadori Editore SpA.

Low resolution image for educational use. Courtesy Denis Ziegler
 Altre Foto e Immagini di ENULA CAMPANA
Altre Foto e Immagini di ENULA CAMPANA